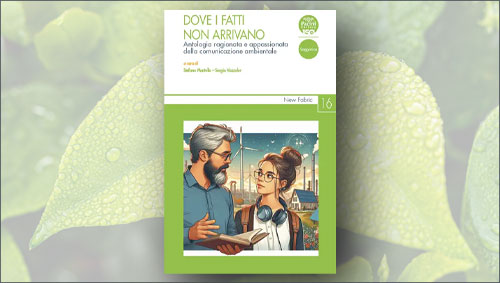Lou Hoffman, presidente e CEO di The Hoffman Agency
La comunicazione della sostenibilità è un mondo serioso e pieno di fatti e cifre, dove non c’è posto per la fuffa, ma le aziende devono trovare il coraggio di parlare anche degli insuccessi e introdurre l’aspetto umano.
Robin Hicks
Le imprese odiano parlare dei propri insuccessi, soprattutto quando si tratta della sostenibilità. Ma se la franchezza non riguardasse solo i successi ma anche i fallimenti, ciò potrebbe aiutarle a evitare di esser noiose, uno dei peggiori peccati nel campo della comunicazione aziendale.
Il consiglio arriva da un veterano delle relazioni pubbliche, Lou Hoffman, presidente e CEO di The Hoffman Agency, una società di consulenza globale con sede a San Jose e specializzata nella tecnologia, che da 30 anni gestisce l’immagine di colossi globali come Google, Avaya, Brother e Fuji Xerox.
“La monotonia – afferma Hoffman in un intervento sulle tecniche di storytelling – è il risultato del lessico specifico della vostra azienda e del linguaggio corporate”.
“Le imprese si presentano poco interessanti anche quando si vantano dei propri successi, brandendo contenuti vanagloriosi che allontanano i lettori” dice Hoffman, la cui agenzia ha pubblicato un rapporto sulle difficoltà dei professionisti PR in Asia a creare contenuti efficaci.
Aggiunge: “Non so quando è iniziato, ma oggi l’atteggiamento delle imprese è del tipo <<L’ho pagato [un’agenzia che produca contenuti], quindi dico tutto quello che voglio>>. Certo, è vero. Ma non volete dire qualcosa che la gente ritiene importante e di cui i giornalisti vogliono scrivere?”
Hoffman riconosce che nel mondo asciutto e cauto della sostenibilità, le aziende tendono ad assumere un tono “clinico e accademico,” e, in effetti, dire le cose come stanno nel campo ambientale e sociale richiede una voce ferma, evitando la fuffa.
Se, invece, si parla apertamente anche dei fallimenti, l’azienda “diventa il difensore civico di sé stesso” ed è in grado di verificare i propri progressi se dovesse trovarsi a gestire questioni difficili in futuro.
Un’impresa che parla di quello che non ha funzionato rende il fatto di dominio pubblico e “versa buona volontà nella banca ideale del karma”. Non solo, il fatto di essere onesti, trasparenti e responsabili, parlando dei propri errori, contribuisce a creare una percezione positiva. Se poi qualcosa va storto in futuro, si ha un materasso per assorbire il colpo.
In questa intervista con Eco-Business, ai margini dell’evento “Mumbrella Asia 360”, Hoffman spiega come la comunicazione della sostenibilità possa non diventare noiosa, perché la fuffa non paga mai e come allineare una storia di sostenibilità con il ciclo delle notizie che diventa sempre più breve.
Qual è il segreto che sta dietro ad una sostenibilità “appealing”?
Nel tentativo di non vantarsi delle proprie realizzazioni, alcune aziende prendono la strada opposta e adottano uno stile clinico, quasi accademico, quando parlano di sostenibilità.
Non credo che sia un approccio negativo, è certamente meglio che vantarsi. Molto spesso la comunicazione della sostenibilità mira a soddisfare un gruppo composito e diversificato di stakeholder, che è una cosa difficile, ma non significa che deve essere noiosa.
Lou Hoffman, presidente e CEO di The Hoffman Agency
La comunicazione della sostenibilità è un mondo serioso e pieno di fatti e cifre, dove non c’è posto per la fuffa, ma le aziende devono trovare il coraggio di parlare anche degli insuccessi e introdurre l’aspetto umano.
Robin Hicks
Le imprese odiano parlare dei propri insuccessi, soprattutto quando si tratta della sostenibilità. Ma se la franchezza non riguardasse solo i successi ma anche i fallimenti, ciò potrebbe aiutarle a evitare di esser noiose, uno dei peggiori peccati nel campo della comunicazione aziendale.
Il consiglio arriva da un veterano delle relazioni pubbliche, Lou Hoffman, presidente e CEO di The Hoffman Agency, una società di consulenza globale con sede a San Jose e specializzata nella tecnologia, che da 30 anni gestisce l’immagine di colossi globali come Google, Avaya, Brother e Fuji Xerox.
“La monotonia – afferma Hoffman in un intervento sulle tecniche di storytelling – è il risultato del lessico specifico della vostra azienda e del linguaggio corporate”.
“Le imprese si presentano poco interessanti anche quando si vantano dei propri successi, brandendo contenuti vanagloriosi che allontanano i lettori” dice Hoffman, la cui agenzia ha pubblicato un rapporto sulle difficoltà dei professionisti PR in Asia a creare contenuti efficaci.
Aggiunge: “Non so quando è iniziato, ma oggi l’atteggiamento delle imprese è del tipo <<L’ho pagato [un’agenzia che produca contenuti], quindi dico tutto quello che voglio>>. Certo, è vero. Ma non volete dire qualcosa che la gente ritiene importante e di cui i giornalisti vogliono scrivere?”
Hoffman riconosce che nel mondo asciutto e cauto della sostenibilità, le aziende tendono ad assumere un tono “clinico e accademico,” e, in effetti, dire le cose come stanno nel campo ambientale e sociale richiede una voce ferma, evitando la fuffa.
Se, invece, si parla apertamente anche dei fallimenti, l’azienda “diventa il difensore civico di sé stesso” ed è in grado di verificare i propri progressi se dovesse trovarsi a gestire questioni difficili in futuro.
Un’impresa che parla di quello che non ha funzionato rende il fatto di dominio pubblico e “versa buona volontà nella banca ideale del karma”. Non solo, il fatto di essere onesti, trasparenti e responsabili, parlando dei propri errori, contribuisce a creare una percezione positiva. Se poi qualcosa va storto in futuro, si ha un materasso per assorbire il colpo.
In questa intervista con Eco-Business, ai margini dell’evento “Mumbrella Asia 360”, Hoffman spiega come la comunicazione della sostenibilità possa non diventare noiosa, perché la fuffa non paga mai e come allineare una storia di sostenibilità con il ciclo delle notizie che diventa sempre più breve.
Qual è il segreto che sta dietro ad una sostenibilità “appealing”?
Nel tentativo di non vantarsi delle proprie realizzazioni, alcune aziende prendono la strada opposta e adottano uno stile clinico, quasi accademico, quando parlano di sostenibilità.
Non credo che sia un approccio negativo, è certamente meglio che vantarsi. Molto spesso la comunicazione della sostenibilità mira a soddisfare un gruppo composito e diversificato di stakeholder, che è una cosa difficile, ma non significa che deve essere noiosa.
La cosa problematica è integrare un fallimento nel racconto e parlare degli sbagli. D’altra parte un’azienda che ha avuto delle difficoltà, che ne ha parlato in modo chiaro e preciso, spiegando le azioni correttive intraprese, diventa il difensore civico di sé stesso quando rivede i propri progressi più in là.Eppure alcune imprese temono di esporsi a critiche da parte delle Ong se ammettono anche i loro insuccessi nel campo della sostenibilità. Cosa direbbe a queste imprese? Potrebbe essere un rischio se l’impresa non ha una soluzione. Ma se si è mossa nella direzione giusta affrontando il problema, non è più in dubbio il fatto che farà la cosa giusta. Quindi perché non parlare delle cose che non sono andate bene? Alcune aziende potrebbero pensare che la cosa più facile sia non dire nulla. È una buona idea? In molti casi, le imprese non comunicano affatto le proprie azioni nel campo della sostenibilità, spesso per i migliori motivi: non vogliono vantarsi.
Ma anche quando le cose non stanno andando male, è sempre meglio comunicare la sostenibilità. Parlandone, si crea una traccia pubblica e si versa goodwill in un’ideale banca del karma. Se poi qualcosa va storto in futuro, si ha un materasso per assorbire il colpo. Si può dimostrare un passato di comportamento corretto, e quindi indicare che il problema è stato un caso isolato.Le storie di sostenibilità sono spesso lente, e si dispiegano nel corso di anni, a volte decenni. Come si fa ad allineare i racconti di sostenibilità con un ciclo informativo sempre più breve? L’elemento che sovente manca in queste storie è la dimensione umana. I racconti di sostenibilità parlano spesso di numeri e quantificano i progressi. Tutto ciò è importante, ma non è tutto. Ad esempio, mia sorella ha una piccola azienda, Under the Nile , specializzata in biancheria intima per bambini, fatta di cotone egiziano biologico. Quello del cotone egiziano è un tema controverso, si contesta il metodo di coltivazione, l’utilizzo di pesticidi, la vendita di tessuti non autentici. L’azienda di mia sorella ha raccontato la sostenibilità anche al livello dei singoli lavoratori, introducendo un elemento di umanità in mezzo a tutti i numeri. In genere quali sono i successi – e gli errori – nella comunicazione della sostenibilità? A mio parere, le imprese non prevedono in modo adeguato i possibili scenari nell’eventualità di una crisi. Oggigiorno molte Ong si comportano in modo imprevedibile, persino spregiudicato. Certo, i controlli e le verifiche sono necessari, e le Ong svolgono un ruolo importante. Ma a volte sembra che mirino solo a distruggere le imprese, quindi le imprese hanno bisogno di un patrimonio pubblico col quale difendersi se sono oggetto di attacchi ingiusti. Qualche anno fa, c’è stato un incidente in un’azienda taiwanese attiva nel campo dei semiconduttori, con il risultato che sostanze chimiche nocive sono state disperse in un fiume. Che fosse colpa di questa azienda non era in dubbio. C’è stato un errore umano, e l’impresa lo ha ammesso. È stato un episodio isolato, ma le Ong l’hanno massacrata. L’azienda pensava che la storia sarebbe stata superata, poiché aveva preso azioni correttive, e non era mai successo niente di simile in precedenza. Ma sbagliava. Internet non dimentica mai, e quando si lanciavano ricerche online sull’azienda, la prima cosa che veniva fuori era sempre l’incidente. Due anni dopo, l’azienda si è rivolta a noi. Come avete risolto il problema? Ormai erano passati due anni e quindi non aveva alcun senso chiedere ai media di correggere la cosa. Invece abbiamo realizzato un sito web, ottimizzato per le ricerche, che raccontava tutta la storia in modo specifico. Controllammo i testi per eliminare gli aggettivi e gli avverbi, volevamo un copy quasi accademico, che presentasse il punto di visto dell’azienda e esprimesse il rimorso per l’accaduto. Inoltre, organizzammo delle ricerche a pagamento legate al sito dedicato. In questo modo l’azienda poteva inserire la propria voce nel contenuto che le persone trovavano nelle loro ricerche. Una voce molto diversa rispetto a quella delle Ong. Funzionò. Dopo 14 mesi, l’azienda poteva smantellare il sito dedicato, ritenendo di aver raggiunto un equilibrio nel dominio pubblico. Ci sono delle imprese con le quali non lavorereste a causa delle loro storie ambientali? Oppure ritenete che ogni azienda ha diritto alla consulenza, a dispetto di tutto? Se ci fosse un’impresa che inquina in modo cronico, e fosse chiaro che i vertici hanno deciso che gli conviene continuare a inquinare e a pagare le sanzioni, non accetterei di lavorare con loro. Nel caso del produttore taiwanese di semiconduttori, dissi che non ero disposto ad accettare l’incarico a meno che non mi convincessero che l’incidente era veramente un caso isolato. Anche noi abbiamo una reputazione da difendere. Non comunichiamo nulla che non sia vero. Vogliamo presentare il cliente sotto la luce migliore, ma non siamo disposti a fabbricare fuffa. Se quella impresa avesse voluto ingannarmi per un paio di giorni – non sono esperto di gestione dell’acqua – l’avrebbe potuto fare. Ma hanno passato del tempo con me, ho visto lo stabilimento e mi hanno spiegato le attività. Dovevo compiere un atto di fede. Ho raggiunto la conclusione che erano in buona fede. FONTE: Eco-Business]]>