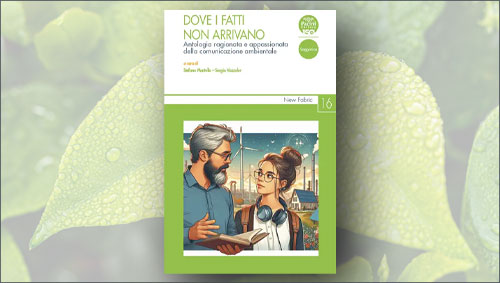Gender Gap 2025: 123 anni per la parità? Troppi, ancora troppi

Secondo i vari ambiti analizzati, esistono ancora disuguaglianze tra donne e uomini nel 68,8% dei casi. Un progresso minimo che non basta. Urge cambiare passo: la DEI non è una casella da spuntare, è una scelta strategica e lungimirante.
Il Global Gender Gap Report 2025 lancia un messaggio tanto chiaro quanto scomodo: al ritmo attuale ci vorranno 123 anni per raggiungere la piena parità di genere nel mondo (l’anno scorso eravamo a 134 anni). Un tempo spropositato, che svela più di ogni altro indicatore il rallentamento sistemico delle politiche di equità.
Il punteggio globale si attesta al 68,8%, in lievissimo miglioramento rispetto al 2024 (+0,3 punti percentuali). Questo significa che c’è ancora il 31,2% di gap da colmare — uno spazio fatto di disuguaglianze nei salari, nelle opportunità di carriera, nella rappresentanza politica, nell’accesso al potere decisionale, alle misure di salute, ecc. Una buona notizia? Solo in apparenza. È il progresso più lento degli ultimi anni, e il fatto che nessun Paese abbia ancora raggiunto la parità piena (neppure quelli in vetta) ci dice molto su quanto ancora la cultura della disuguaglianza sia radicata nelle strutture economiche e politiche globali.
Europa in testa, ma ancora lontana dal traguardo
L’Europa si posiziona al secondo posto tra le regioni globali, con un divario chiuso del 75,1%. Otto dei primi dieci Paesi nel ranking sono europei — Islanda (92,6%), Finlandia, Norvegia, Svezia, Germania, Irlanda, Moldova e Regno Unito — ma anche in questo caso il risultato nasconde grandi disparità interne.
La partecipazione economica femminile resta disomogenea, con solo il 37,5% dei Paesi europei che ha colmato almeno tre quarti del divario in questo ambito. Sul fronte educativo invece i risultati sono più rassicuranti: un terzo del continente ha raggiunto la parità, e la restante parte è vicinissima (entro 5 punti percentuali).
Interessante notare che la parità politica in Europa (35,4%) è la più alta tra tutte le regioni, ma ancora ben lontana dal 50%. Ministeri e parlamenti sono oggi più accessibili alle donne, ma la leadership politica resta prevalentemente maschile, soprattutto nei ruoli chiave di potere e nei dicasteri economici e strategici.
Politica ed economia: le due zavorre della parità
I dati del report parlano chiaro: la parità è più vicina nella salute e nell’istruzione, ma resta lontana nel lavoro e nella politica, ovvero in quelle aree che modellano potere, reddito e influenza. La partecipazione economica femminile è ferma al 61%, e quella politica al 22,9%.
Un dato preoccupante è che, nonostante l’aumento della presenza femminile nell’istruzione terziaria, le donne sono ancora sottorappresentate nei ruoli di leadership economica: solo il 28,1% delle posizioni manageriali è occupato da donne (dato globale), e la curva di crescita si è appiattita dopo il 2022.
Anche sul versante politico, il progresso è reale ma troppo lento: ci vorranno 162 anni per chiudere il gender gap in questo ambito, con un miglioramento annuo troppo modesto rispetto alla portata del problema. E i ruoli più influenti — ministeri economici, difesa, affari esteri — continuano a essere in larga parte appannaggio maschile.
Rompere i silos, uscire dalla retorica
Per chi lavora nei contesti DEI, questi dati confermano una realtà ben nota: la parità non è solo una questione culturale o normativa, ma sistemica. Non si tratta solo di “aprire le porte” alle donne, ma di riconfigurare le strutture organizzative, i criteri di selezione, i sistemi di incentivo, i modelli di leadership.
E questo vale per ogni economia, indipendentemente dal suo livello di sviluppo: alcuni Paesi a basso reddito hanno colmato il gap più rapidamente di quelli più ricchi, segno che l’impegno e le politiche mirate fanno la differenza, più del PIL (a volte).
Il report sottolinea anche una nuova disconnessione: le donne superano gli uomini nell’istruzione, ma questa eccellenza non si traduce in equa partecipazione alla vita economica. Il motivo? Bias impliciti, strutture di carriera non inclusive, mancanza di politiche di conciliazione vita-lavoro. E un peso di cura extra-professionale che ancora grava troppo su un solo genere.
Opportunità da cogliere (non solo obblighi da rispettare)
Il report evidenzia anche le nuove sfide e opportunità. La transizione ecologica, la digitalizzazione e l’economia della cura sono settori dove l’inclusione può accelerare il cambiamento, e dove una presenza femminile più equilibrata potrebbe portare innovazione, diversificazione e resilienza.
In particolare, il dato sulla partecipazione femminile al lavoro (41,2%) e il permanere di forti segregazioni occupazionali (le donne sono il 58,5% nei settori della cura, ma molto meno nei settori tecnologici e infrastrutturali) pone un tema urgente di redistribuzione delle competenze e delle opportunità.
Il report lancia anche un monito sui gap retributivi e sull’impatto dei carichi di cura: le donne sono ancora il 55,2% più propense degli uomini a prendersi pause di carriera, con conseguenze su salari, progressioni e autonomia economica.
Parità: da obiettivo a prerequisito
Ogni anno il Gender Gap Index ci invita a fare il punto. Quest’anno, più che mai, ci sfida a non accontentarci dei progressi marginali. È tempo di alzare l’asticella, dentro le imprese e nelle politiche pubbliche.
Non si tratta di correre solo per migliorare i numeri. Si tratta di costruire un sistema più giusto, che non sprechi il talento, che metta le persone nella condizione di dare il meglio, qualunque sia il loro genere. Un sistema che, finalmente, veda la diversità come motore di crescita, non come sfida da gestire.
Ma per farlo serve distinguere bene tre concetti che spesso si confondono:
- Uguaglianza significa che tutte e tutti hanno le stesse opportunità.
- Equità significa mettere ogni persona nelle condizioni di partire dallo stesso punto, tenendo conto delle differenze reali e delle barriere specifiche che ciascuna affronta.
- Giustizia significa eliminare quelle barriere strutturali, spesso invisibili ma potentissime, che impediscono a queste condizioni di esistere davvero.
Senza questa consapevolezza — e senza un’azione coerente — il tempo stimato per chiudere il gender gap non potrà che allungarsi. E con esso, si allontaneranno anche le opportunità di costruire un’economia più inclusiva, resiliente e lungimirante.
Emilia Blanchetti, senior consultant DEI Amapola