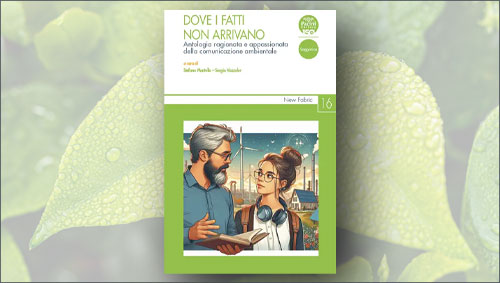Europa e clima: -90% di emissioni entro il 2040, ma il cammino è in salita

La Commissione Europea fissa un obiettivo storico, ma rimangono resistenze interne, clausole di flessibilità e incertezze politiche.
A inizio luglio la Commissione Europea ha confermato un obiettivo che farà da stella polare per la politica climatica del prossimo decennio: ridurre del 90% le emissioni nette di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Un passo intermedio – e tutt’altro che simbolico – verso la neutralità climatica al 2050, in linea con l’Accordo di Parigi.
La proposta, che modifica la Legge europea sul clima, punta a costruire un quadro normativo stabile e credibile, capace di orientare investimenti, innovazione e politiche industriali. Ma il contesto è complesso: il Parlamento europeo ha già respinto la procedura d’urgenza, con 379 voti contrari, rallentando l’iter legislativo. Intanto si avvicina la scadenza della COP30 in Brasile, dove l’UE dovrà presentare un piano concreto per il 2035. Pena: l’esclusione dal processo di conteggio globale delle Nazioni Unite.
Il compromesso possibile: rigore con flessibilità
Il nuovo obiettivo non arriva dal nulla. È il risultato di una lunga elaborazione politica, scientifica e diplomatica. Già nel 2023 il Comitato Scientifico europeo (ESABCC) aveva chiarito che un taglio delle emissioni tra il 90 e il 95% entro il 2040 era la soglia minima per restare entro gli 1,5°C di riscaldamento globale.
Ma non viviamo in un mondo ideale: siamo in una delle fasi più frammentate e conflittuali della storia politica europea. Per questo la Commissione ha scelto un equilibrio pragmatico, introducendo tre clausole di flessibilità che accompagnano l’obiettivo:
- Uso limitato di crediti di carbonio da Paesi terzi: a partire dal 2036, sarà possibile compensare fino al 3% delle emissioni europee acquistando crediti generati da progetti climatici in Paesi extra-UE, purché questi rispettino criteri di qualità e integrità. Tali crediti non entreranno nel sistema ETS (il mercato europeo delle emissioni), ma verranno contabilizzati separatamente. Si tratta di una riapertura – molto più regolata – rispetto al meccanismo CDM del Protocollo di Kyoto, oggi sostituito dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
- Integrazione delle rimozioni permanenti di CO₂ nel mercato ETS, dal 2030: si tratta di interventi capaci di assorbire CO₂ in modo stabile, come riforestazione, gestione del suolo o tecnologie di cattura e stoccaggio (CCS, Carbon Capture and Storage). Saranno regolati dal CRCF (Carbon Removals and Carbon Farming Regulation), adottato nel 2024, e permetteranno di compensare parte delle emissioni industriali difficili da abbattere.
- Flessibilità settoriale: sarà possibile spostare gli sforzi tra settori, permettendo, ad esempio, che le performance migliori di settori più virtuosi (come i trasporti) possano bilanciare le difficoltà di comparti più lenti (come agricoltura o edilizia). Lo schema è ancora in fase embrionale, ma risponde a esigenze di equità e bilanciamento interno.
Una scelta che ha fatto storcere il naso agli ambientalisti più radicali, ma che si rivela funzionale alla tenuta dell’impianto europeo. Come ha scritto il giornalista Ferdinando Cotugno:
“Non è la transizione dei nostri sogni, ma è un compromesso utile. È questo che fanno le democrazie: trovano un modo quando è più difficile.”
Il rischio dell’immobilismo: tra freni interni e geopolitica ostile
Le divisioni interne all’Unione sono reali. Il Partito Popolare Europeo ha bloccato la procedura rapida e molti governi – Germania in testa – hanno spinto per inserire i crediti internazionali nel pacchetto climatico, in cambio del consenso al -90%.
Ma c’è un’altra questione che Bruxelles non può ignorare. Mentre gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, si sfilano dagli accordi sul clima, e molte economie emergenti fissano obiettivi lontani (India al 2070, Cina e Arabia Saudita al 2060), l’UE rischia di restare l’unico gigante verde in un mondo grigio. Eppure, proprio questa “solitudine virtuosa” potrebbe essere la chiave per riaffermare un ruolo di leadership nella diplomazia climatica.
Una sfida europea… e sociale
L’obiettivo del -90% impone un cambio di passo titanico. Vuol dire trasformare i modelli di produzione, mobilità, energia e consumo. Ma anche redistribuire lo sforzo tra Paesi, settori e cittadini.
Come garantire che questa transizione sia socialmente giusta? Dove si colloca il dibattito su un vero welfare climatico, capace di prendersi carico delle sfide che già oggi la crisi climatica impone, e allo stesso tempo gettare le basi per una transizione graduale che non lasci indietro nessuno?
In un contesto di crescente polarizzazione, il sostegno pubblico si manterrà solo se la transizione sarà equa e ben comunicata.
Il tempo stringe. E non perdona
La scienza parla chiaro: dal 1997, anno del Protocollo di Kyoto, le emissioni globali sono cresciute del 55%. E anche l’ultimo decennio, seppur più lento, segna un +7%. Se vogliamo invertire la rotta nei prossimi 25 anni, servono obiettivi chiari, strumenti coerenti e un’azione collettiva ambiziosa.
Il cammino è accidentato, pieno di ostacoli, contraddizioni e compromessi. Ma anche di possibilità concrete. L’alternativa – l’inazione – non è più sul tavolo. Il clima non aspetta e l’Europa non può permettersi di essere l’anello debole.
Prima di tutto, la credibilità
Quella del -90% non è una promessa. È un invito a misurarsi con la realtà. L’Europa ha scelto di tenere la barra dritta, anche quando è difficile. Ma adesso servono coerenza, coraggio e capacità di coinvolgere tutta la società.
Il clima non si governa con le scorciatoie. Se la democrazia climatica è disordinata – e forse a volte troppo propensa al compromesso rispetto alle nostre aspettative – è anche il nostro unico strumento per non perdere il controllo della rotta.