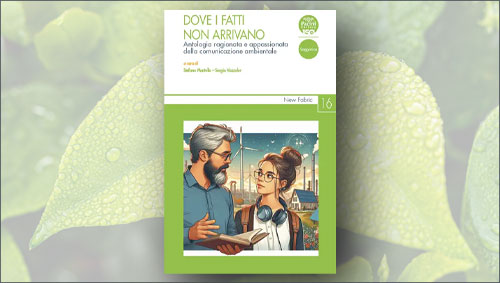Parità retributiva: l’equità non può più aspettare

L’Equal Pay Day ci ricorda che le disuguaglianze economiche tra uomini e donne sono ancora profondamente radicate. In Italia, il divario può arrivare anche fino al 40%. La parità retributiva è ancora lontana e non possiamo più rimandare.
Ogni 18 settembre si celebra l’International Equal Pay Day, una giornata istituita dalle Nazioni Unite che punta i riflettori sulla parità retributiva, rivelando un’ingiustizia tanto antica quanto attuale: le donne nel mondo guadagnano ancora significativamente meno degli uomini, a parità di lavoro. Una giornata che ha scelto un nome positivo – equal pay, non pay gap – per spingere verso un traguardo, piuttosto che piangere un’assenza. Ma la realtà, purtroppo, è ancora molto distante dall’equità.
Il divario retributivo di genere globale si attesta intorno al 20%, secondo le stime ONU. In Europa, le donne guadagnano in media il 12% in meno all’ora rispetto ai colleghi uomini (dati Eurostat). In Italia, la forbice può arrivare al 40% in alcuni settori. Si tratta di una vera e propria disuguaglianza sistemica, riflesso di poteri squilibrati, barriere culturali, ruoli familiari non redistribuiti e mancanze di normative (anche se qualcosa a livello europeo si sta muovendo, vedi più avanti).
Parità retributiva: un problema strutturale, non episodico
Il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum è eloquente: il divario di genere globale è stato colmato solo al 68,8%. E se il progresso continua a questi ritmi, ci vorranno 123 anni per raggiungere la parità. Le due aree più critiche sono proprio quelle che definiscono il potere: la partecipazione economica (colmata al 61%) e l’empowerment politico (fermo al 22,9%).
Il gap retributivo non riguarda solo il salario in sé, ma tutto ciò che lo determina:
- interruzioni di carriera legate alla maternità (le donne hanno il 55% in più di probabilità di interrompere il lavoro rispetto agli uomini);
- sottorappresentazione nei ruoli apicali (solo il 21,1% dei dirigenti in Italia è donna);
- segregazione settoriale, con una forte presenza femminile in comparti meno remunerativi come assistenza, cura, istruzione;
- discriminazioni implicite nei processi di assunzione, promozione e valutazione.
In Italia la parità retributiva resta lontana, anche per le laureate
Come già ricordato, secondo il Rendiconto di genere INPS 2024, le donne italiane guadagnano in media il 20% in meno degli uomini. Ma la media non dice tutto: nel settore immobiliare il gap raggiunge il 39,9%, e nelle attività scientifiche e tecniche il 35,1%.
Il dato più amaro? Anche le giovani laureate, nonostante si laureino meglio, iniziano con stipendi inferiori e rimangono in svantaggio per tutta la carriera. Come se l’intera traiettoria lavorativa fosse “programmata” per il secondo posto. E nel Mezzogiorno, dove l’occupazione femminile è già fragile, l’istruzione attenua ma non annulla il divario.
Molto significativi anche i dati sui congedi parentali: nel 2023 le donne hanno usufruito di 14,4 milioni di giornate, contro appena 2,1 milioni per gli uomini. E qui forse non si può non citare una legge nazionale in cui gli uomini hanno diritto a soli 10 giorni di congedo alla nascita di un figlio o di una figlia, rispetto ai cinque mesi di maternità per le donne. Molto eloquente.
L’Europa prova a reagire: normative e trasparenza
L’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sancisce: stessa retribuzione per un lavoro di pari valore. Un principio sacrosanto, ma ancora poco praticato.
Dal 2026 entrerà in vigore la Direttiva UE sulla trasparenza salariale, che obbligherà le aziende a rendere pubblici gli stipendi e le strutture retributive, favorendo il diritto all’equità e contrastando le discriminazioni opache. In Italia, dal 2021 è attiva anche la certificazione volontaria per la parità di genere, che si concentra anche sulla presenza o meno (e in che percentuale) del gender pay gap in azienda.
Benché siano sempre di più le imprese certificate, la strada è ancora lunga, soprattutto nelle PMI, dove la cultura della parità fatica ad attecchire, spesso per mancanza di risorse o per inerzia organizzativa.
Violenza economica: il volto nascosto del divario salariale
Parlare di gap retributivo senza citare la violenza economica è fare un discorso a metà. Perché quando una donna non ha indipendenza economica, è più esposta a situazioni di dipendenza, ricatto, isolamento. È il primo anello di una catena che può arrivare fino alla violenza fisica.
L’autonomia finanziaria non è solo un tema di giustizia sociale. È una condizione di libertà personale. Ridurre il gender pay gap significa anche, in termini concreti, rendere le donne più libere di scegliere, più forti nel rivendicare diritti, più sicure nel rifiutare situazioni tossiche.
Più che una questione salariale, impatti macroeconomici
Il gender pay gap ha anche un costo per la collettività. Secondo le stime del McKinsey Global Institute, colmare il divario di genere nel lavoro potrebbe aumentare il PIL globale del 26% entro il 2025. In Europa significherebbe aggiungere circa 2.800 miliardi di euro all’economia.
Eppure, continuiamo a ignorare questo potenziale. Le donne che lavorano sono meno, sono pagate meno e lavorano più spesso part-time. Uno spreco di talento e risorse che non ci possiamo più permettere.
Parole giuste, azioni responsabili
La scelta delle Nazioni Unite di intitolare la giornata all’“Equal Pay” anziché al “Gender Pay Gap” è significativa. Sottolinea l’obiettivo da raggiungere, non solo la ferita da curare. È una chiamata all’azione positiva, ma non deve farci dimenticare la brutalità dei numeri e l’ingiustizia sistemica che li genera.
L’equal pay non è un “nice to have”. È una priorità sociale, economica e democratica. Serve una svolta concreta per garantire parità retributiva, partendo dalle imprese, dalle istituzioni e da chi, ogni giorno, prende decisioni su stipendi, carriere, welfare e cultura aziendale.
È giusto parlare di equità, ma guai a edulcorare il problema. Serve un cambiamento profondo, culturale, normativo e organizzativo. Serve coraggio, serve responsabilità.