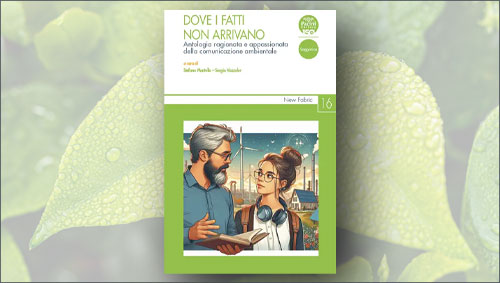Doppia materialità: da obbligo tecnico a strumento strategico

La DMA (Double Materiality Assessment – assessment di doppia materialità) è un alleato della strategia, non solo del reporting. Perché tutte le aziende dovrebbero farla propria – ora.
Con l’entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), è cambiato radicalmente il modo in cui le imprese sono chiamate a rendicontare la propria sostenibilità. Al di là dell’obbligo della CSRD – attualmente sospeso dal meccanismo ‘stop-the-clock’ del Pacchetto Omnibus – l’analisi di doppia materialità resta uno strumento prezioso e valido per qualsiasi processo di rendicontazione, capace di orientare le decisioni strategiche e di collegare impatti e rischi reali dell’organizzazione. Questo tipo di analisi rappresenta uno snodo cruciale per rendere il reporting utile, strategico e allineato ai reali impatti e rischi delle organizzazioni.
Le ultime indicazioni di EFRAG, emerse nel contesto della revisione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), lo confermano: la doppia materialità resterà. Ma sarà più chiara, meno gravosa e più vicina ai processi decisionali.Anche per le aziende che non rientrano nell’obbligo della CSRD, la doppia materialità rimane uno strumento valido: adottarla volontariamente permette di orientare le scelte aziendali a partire dagli impatti, dai rischi e dalle opportunità ESG, rafforzando così la strategia e la responsabilità dell’organizzazione.
Doppia materialità: l’approccio inside-out/outside-in
La doppia materialità si fonda sull’incrocio tra due prospettive interdipendenti. Da un lato, la materialità d’impatto, che analizza le conseguenze – sia positive che negative – delle attività aziendali su persone, ambiente e società. Gli impatti negativi vengono valutati secondo criteri di gravità (entità, ampiezza, irreversibilità) e probabilità, mentre quelli positivi in base alla loro portata, significatività e potenziale.
Dall’altro lato c’è la materialità finanziaria, che considera in che modo i fattori ambientali, sociali e di governance possano incidere sul valore economico dell’impresa: performance, flussi di cassa, accesso ai capitali, costo del credito.
Entrambe le dimensioni si valutano su un orizzonte temporale che va dal breve al lungo termine (oltre i cinque anni). Questa doppia lettura – spesso descritta come approccio inside-out / outside-in – aiuta a mettere a fuoco ciò che davvero conta per l’azienda: non solo ciò che può danneggiare o valorizzare il business, ma anche ciò che il business genera nel contesto in cui opera.
Una chiave per leggere e gestire la complessità
Parlare di doppia materialità oggi significa parlare di strategia, governance e posizionamento competitivo. Non è più (solo) un esercizio legato al bilancio di sostenibilità, ma uno strumento per decidere meglio: quali rischi sono da presidiare, quali impatti sono da ridurre, dove si aprono opportunità concrete.
Questo approccio diventa particolarmente utile per le imprese che vogliono gestire la complessità ESG senza subirla. In un contesto di crescente pressione da parte di clienti, investitori, banche e territori, la doppia materialità offre una mappa per orientarsi – tanto nelle decisioni quotidiane quanto nella pianificazione di medio-lungo periodo.
Dalla teoria alla pratica: cosa cambia nei processi aziendali
La doppia materialità porta le aziende a rimettere in discussione abitudini consolidate:
- Il coinvolgimento degli stakeholder smette di essere un obbligo formale e diventa uno strumento per comprendere meglio il contesto, i segnali deboli, le aspettative future.
- La valutazione dei rischi si amplia oltre le logiche finanziarie classiche: non si tratta solo di difendere il valore dell’impresa, ma anche di comprenderne la capacità di generarlo nel tempo.
- La pianificazione strategica integra gli impatti ambientali e sociali, diventando più aderente alla realtà e più coerente con le aspettative del mercato e della società.
- I flussi informativi interni si riorganizzano: servono nuove collaborazioni tra le funzioni sustainability, risk management, pianificazione strategica, controllo di gestione, operations.
In sintesi: la doppia materialità impone di pensare per relazioni e non per silos.
Le quattro fasi della doppia materialità: la bussola EFRAG
Per strutturare efficacemente il processo, l’EFRAG propone un modello in quattro fasi. È un percorso che può essere calibrato su misura, ma che offre un riferimento utile per tutte le imprese:
- Comprendere il contesto (fase A)
Mappare il modello di business, le attività lungo la catena del valore, i rischi e le dipendenze strategiche. In questa fase si analizzano anche gli stakeholder chiave e si confrontano le attese del settore. - Identificare impatti, rischi e opportunità (fase B)
Partendo da una “long-list”, si analizzano gli impatti ESG rilevanti (positivi e negativi), sia diretti che lungo la filiera. È il momento di raccogliere dati, indicatori e punti di vista interni. - Valutare la rilevanza (fase C)
Si combinano impatti e rischi finanziari, utilizzando criteri oggettivi e coerenti. È fondamentale il coinvolgimento degli stakeholder interni (funzioni chiave) ed esterni (esperti, rappresentanti di interessi qualificati). - Rendicontare e integrare (fase D)
L’output dell’analisi serve per costruire il bilancio di sostenibilità, ma anche per orientare KPI, obiettivi, azioni strategiche e processi interni.
Il processo può essere affrontato in modo top-down o bottom-up, a seconda del livello di maturità dell’impresa. Ma ciò che conta è che sia solido, trasparente e utile alla strategia.
Stakeholder engagement: dalla consultazione alla co-decisione
Il coinvolgimento degli stakeholder non è più un passaggio “nice to have”. È il cuore del processo.
Ma serve una svolta: non si tratta solo di fare survey o focus group. Serve costruire relazioni di fiducia, abilitare il dialogo con soggetti esperti, individuare quelli che possono veramente arricchire l’analisi di materialità.Per le PMI, questo può voler dire avviare conversazioni più strutturate con clienti, fornitori, comunità locali. Per le grandi imprese, può significare rafforzare le interazioni con investitori, analisti ESG, ONG o policy maker. Per tutte le realtà significa porre le basi di una relazione strategica e duratura con tutti quei soggetti e quelle organizzazioni che possono influenzare l’operato dell’azienda.
Una leva per la resilienza e la competitività
Quando ben progettata, la doppia materialità aiuta le aziende a:
- definire priorità strategiche basate su dati concreti e su visioni condivise,
- evitare reporting “bulimici” o generici,
- migliorare la qualità della comunicazione interna ed esterna,
- aumentare la capacità di risposta ai rischi (climatici, finanziari, sociali, reputazionali),
- innovare modelli di business, individuando aree di impatto positivo ancora non presidiate.
È qui che la doppia materialità fa la differenza: non come adempimento, ma come driver di trasformazione.
La materialità non è un filtro, è un volano
Per le imprese che vogliono orientarsi nel presente e progettare il futuro, la doppia materialità rappresenta una risorsa strategica. Non si tratta di raggiungere la “compliance perfetta”, ma di costruire un processo coerente, proporzionato e dinamico, capace di adattarsi nel tempo e di generare valore.
Anche per chi è fuori dagli obblighi normativi, la doppia materialità può diventare un marchio distintivo di serietà e lungimiranza: un segnale concreto per stakeholder, partner, finanziatori.
Non un semplice filtro per escludere o includere i temi di interesse dell’azienda, ma una vera e proprio leva per capire dove agire.